Parlare di razzismo in Italia, è diventato quasi un tabù. Se osi definire razzista qualcuno che porta avanti idee che puntano alla discriminazione e all’esclusione e incitano alla violenza, ti risponderanno che non c’è alcun razzismo, che si tratta solo di esasperazione legata a questioni sociali irrisolte che la crisi ha reso esplosive. Se ti spingi a definire razzista una frase o, ad esempio, una ingiustificata aggressione a dei rifugiati che non hanno alcuna responsabilità di ciò per cui vengono accusati, ti dicono che devi allargare i tuoi orizzonti o che sei ideologizzato. Da più parti, persino da quelle che dovrebbero appartenere all’area di chi ha sempre condannato discriminazioni e ingiustizie, emerge una sorta di rifiuto automatico dell’idea che in Italia si sia ormai radicata una pericolosa cultura razzista, fatta di parole agghiaccianti e di azioni brutali, con conseguenze concrete.
Per molti, perfino a sinistra, quando Salvini, la Meloni e Grillo attaccano i migranti, sfoderando la falsa equazione “immigrato uguale criminale” o diffondendo il falso allarme delle malattie che i migranti porterebbero in Italia, forse usano toni duri ma non sono razzisti. Per Galli della Loggia, ad esempio, editorialista del Corriere della Sera, le forze politiche che incitano all’odio e alla violenza fanno solo il loro gioco e ciò, a suo modo di vedere, è assolutamente normale e logico. Guai a parlare di razzismo. Insomma, per chi proferisce verbo dalla tv e dagli scranni della politica il nostro non è un paese razzista, ma anzi è fin troppo tollerante. E a nessuno è consentito obiettare. Per la gente, che si ciba sempre più di politica e tv e sempre meno di libri e di dati, l’Italia è una terra che accoglie tutti, “anche troppo”, e che per questo suo eccesso di bontà si ritrova “invaso” da “delinquenti stranieri” che “stuprano”, “rubano”, “uccidono”, ci “tolgono il lavoro” e ci “impoveriscono”. Insomma, gli italiani sono sempre quelli a cui nessuno, a loro parere, potrà strappare l’antica (quanto qualunquista) definizione di “brava gente” a cui tanto sono affezionati.
Se ne infischiano se ti ostini a spiegare: che il numero di rifugiati in Italia è esiguo; che la quantità di migranti è di gran lunga più bassa della gran parte dei paesi europei e di molti paesi mediorientali e persino africani; che il numero totale dei reati in Italia è nettamente inferiore agli anni nei quali nel nostro paese praticamente non c’erano immigrati e che la grande maggioranza di essi non delinque (e quelli che delinquono occupano posizioni di bassa manovalanza, a fronte invece di almeno quattro mafie italiane e un tasso di corruzione politica interna raccapricciante); che la maggior parte delle violenze sessuali (oltre l’80%) è commesso da italiani all’interno dei gruppi familiari e amicali; che i migranti non ci tolgono il lavoro, visto che svolgono attività di basso livello che gli italiani non vogliono più fare (preferendo la lamentela contro lo Stato); che i migranti svolgono spesso lavori di grande importanza sociale (basti pensare all’assistenza ai malati e agli anziani) e che con il loro lavoro producono l’11% del Pil che permette alla nostra economia di non crollare e ai nostri pensionati di percepire un reddito; che non ci sottraggono servizi né soldi, considerato che la spesa sociale per i migranti è pressoché nulla (essendo giovani non percepiscono pensione e la spesa sanitaria è irrilevante).
La verità rimane sepolta insieme al concetto di razzismo, la cui esistenza, tra coloro che continuano a mentire e a diffondere menzogne e tra coloro che vi credono e che sulla base di tali menzogne attuano le azioni più ignobili, viene negata continuamente. Anche davanti all’evidenza. Un costume che è soprattutto italiano.
A tal proposito, mi viene in mente una cosa che mi accadde poco più di sette anni fa. Durante un’intervista per un libro, chiesi a Giovanni Maria Bellu, che all’epoca era una delle firme di punta di Repubblica, se a suo parere l’Italia fosse o meno un paese razzista. La sua risposta fu talmente bella che la incorniciai nella mia memoria, al punto che ancora oggi, quando ve n’è occasione, me ne servo: “In una mia rubrica di Repubblica (Gli altri noi) – mi disse – parlo di un tipo di soggetto per cui ho coniato il termine norappero. Si tratta di una parola che ho inventato per descrivere la figura tipica dell’italiano che dice ‘non sono razzista, però’. Allora, facendo una ricerca su Internet, con tutta l’approssimazione che può avere, su un motore di ricerca qualsiasi, digitando la frase in diverse lingue, ti accorgi che si tratta di un’espressione tipicamente italiana, che è il frutto di un determinato tipo di sviluppo culturale”.
La frase, infatti, come mi spiegò Bellu, determinava oltre diecimila risultati in italiano, mentre in altre lingue, ad esempio in inglese o francese, i risultati erano molto inferiori ai mille. Quando chiedevo il perché di questa abitudine tutta italiana, egli rispondeva che “siamo un Paese che ha avuto un’educazione o marxista o cattolica. Ci siamo formati o nelle sezioni di partito o in ambienti di sinistra o negli oratori. Allora il non razzismo, il fatto dell’improponibilità e del rifiuto del razzismo è una cosa che accomuna assolutamente ogni tipo di formazione. Cioè, un ragazzo di una famiglia cattolica o di una famiglia comunista, entrambi alla stessa maniera sapevano che il razzismo fosse inammissibile. Ancora oggi, infatti, se si fanno dei sondaggi, alla domanda secca ‘lei è razzista?’ quasi tutti rispondono di no. È un vero tabù”.
Nulla di più vero. Sono certamente molti di più quelli che dopo aver premesso di non essere razzisti, vomitano parole violente e inaccettabili, rispetto a quelli (che sono comunque in aumento oggi) che si definiscono razzisti apertamente o col tono di chi te lo dice quasi sarcasticamente a sottolineare la propria rabbia. Ultimamente abbiamo constatato più volte questo tipo di atteggiamento: “Se pensarla così significa essere razzista, allora, d’accordo, vuol dire che lo sono!”; “se essere razzisti significa difendere i diritti del mio popolo o difendere la mia famiglia, allora sono fiero di essere razzista!”. Insomma, in questa nazione poco accogliente, la tolleranza è elevata solo nei confronti delle parole più truci e dei concetti più violenti.
Non è ancora comprensibile, in questo clima di perverso patriottismo e di rozza autodifesa, cosa bisogna fare o dire per essere considerati razzisti. È così assurdo sostenere che davanti a frasi che incitano a bruciare vivi tutti i neri o a mettere nei forni crematori i rom non basti un fottuto “però” a riparare dalla definizione sacrosanta di razzismo? Sarebbe bello sapere, dai benpensanti di ogni area, se per loro esiste o meno un limite oltre il quale un’idea, una frase, un gesto possano essere condannabili e tacciati di razzismo, frantumando così quel diffuso tabù italiano certificato da una ipocrita quanto irritante congiunzione avversativa.
Massimiliano Perna –ilmegafono.org


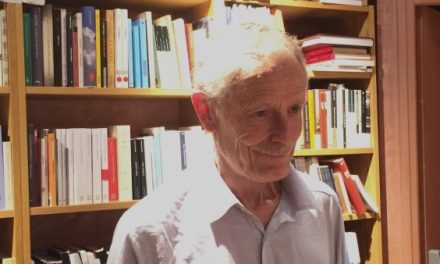



 👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢
👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti