I sintomi di un Paese che ha un serio problema con la tutela dei diritti delle donne sono molteplici, così come lo sono i loro effetti e le loro manifestazioni. Sono sintomi che testimoniano il perdurare di un problema culturale che va oltre la violenza fisica o psicologica. Sono normalmente rintracciabili, ma spesso si nascondono dietro concetti, parole, reazioni insolite. In qualsiasi caso, sono irritanti e producono spasmi nel corpo di una democrazia sempre più fragile, incapace di fare i conti con lo squilibrio feroce nel rapporto tra i diversi generi. È una questione annosa che, malgrado i passi avanti dovuti a chi da decenni lotta contro le discriminazioni, continua a creare mostri, orrori, mentalità pericolosamente sopraffacenti. L’Italia ha seri problemi in materia di diritti delle donne e li ha perché è un Paese profondamente chiuso, in buona parte ingabbiato in un maschilismo che si ripete quotidianamente in ogni ambito. C’è sempre uno squilibrio, perfino in quelle situazioni nelle quali non dovrebbe essercene più, perché ha già prodotto i suoi orrori e dovrebbe lasciare spazio quantomeno al rispetto e alla riflessione.
La vicenda di Giulia Cecchettin ha toccato il Paese, o almeno una parte di esso, e ha spinto chi già lottava a continuare a farlo, per pretendere che la violenza venga fermata prima di arrivare al suo culmine fatale. E non ci si riferisce meramente a una questione di repressione o di azione giuridica, ma ci si riferisce soprattutto a una questione educativa, culturale, di formazione. Perché la violenza è prima di tutto l’espressione di uno spettro di linguaggi, logiche, visioni che collettivamente finiscono per condannare il maschilismo, la sopraffazione, le discriminazioni solo quando la cronaca ci offre volti, nomi, storie drammatiche di morti che si sarebbero potute evitare. Per legge, ma soprattutto per cultura. Il linguaggio e le mentalità, infatti, uccidono come i coltelli e le pistole, sono la base su cui si edifica l’orrore. Ribellarsi a quel linguaggio riguarda ciascuno di noi, donne e uomini, perché se una parola scorretta o una desinenza sbagliata, così come una battuta sessista, passano lisce, vengono minimizzate e lasciate scorrere nella società quotidiana, allora siamo tutti colpevoli di non aver fatto abbastanza. In quanto il linguaggio e l’opportunità del suo utilizzo costruiscono poi lo schema di valori dominante.
Con tutto quel che ne deriva. Nel caso di Giulia Cecchettin, abbiamo visto come questo schema sia diventato carburante per l’idea omicida di un 22enne, Filippo Turetta, incapace di fermare la sua ossessione maschilista, il suo senso di dominio, l’arroganza feroce che porta a spezzare la vita di una ragazza solo perché si ribella a quella ossessione, all’idea di essere oggetto di possesso e controllo. La mano di Turetta non è quella di un soggetto “malato”, come ha in qualche modo provato ad asserire, goffamente, l’avvocato della difesa. La mano di Turetta è quella di un ragazzo cresciuto dentro una società che guarda con fastidio, a qualsiasi età e livello, la libertà delle donne, la loro possibilità di scegliere. Un ragazzo ossessivo e molesto, che ha studiato un piano per ucciderla e lo ha fatto colpendola con un numero impressionante di coltellate, per poi occultare il corpo e scappare all’estero. Uno scenario lontano da quello di un raptus irrazionale e molto più in linea con un atto di premeditata crudeltà nei confronti di una ragazza che aveva solo provato, con tatto e sensibilità (anche in eccesso), a riprendersi la sua vita.
Ecco perché ha ragione Elena Cecchettin, sorella di Giulia, quando esprime il suo pensiero critico sulla sentenza. E torniamo al punto precedente, torniamo ai sintomi. Elena è la sorella di chi è stata uccisa, è una familiare della vittima, per usare un’espressione tanto cara ai cronisti. La sentenza che ha escluso l’aggravante dello stalking e della crudeltà, per quanto giuridicamente spiegabile, è stata aspramente criticata, con un ragionamento molto più complesso di quello che tanti osservatori hanno messo in evidenza negativamente. È una cosa del tutto consueta che i familiari si ribellino a una giustizia che non ritengono compiuta fino in fondo, e tante volte questo porta a parole irrazionali e sconnesse. Nessuno, se non al massimo la controparte coinvolta, si sogna però di rispondere, di replicare. Peraltro, le parole di Elena Cecchettin, affidate a un post su Instagram, non sono affatto sconnesse e irrazionali, ma hanno una logica, filano, sono chiare.
La ragazza parla di come il non riconoscimento dell’aggravante di stalking, in particolare, sia un colpo alle donne, un’occasione mancata per punire comportamenti che arrivano ben prima della violenza: “Il non riconoscimento dello stalking (non parlo nemmeno dell’altra aggravante, la crudeltà, perché si commenta da sola la situazione) – afferma nel suo post – è un’ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne. Sei vittima solo se sei morta”. Ma il ragionamento di Elena Cecchettin va oltre, supera il dolore personale: “Chi sostiene che tanto la condanna sarebbe stata la stessa anche con le altre due aggravanti non ha capito nulla. Se nulla può portarci indietro Giulia quanto meno può fare la differenza per altre donne nel futuro. È facile rinchiudere in cella per sempre una persona lavandosene le mani poi e dicendo di aver fatto giustizia. Ma è questa la vera giustizia?” “Sì, fa la differenza riconoscere le aggravanti – continua Elena – perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove è presente il coltello o il pugno. Ma molto prima. E significa che abbiamo tempo per prevenire gli esiti peggiori. Sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e il menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio”.
A queste parole, allo sfogo lucido di chi ha perso drammaticamente una sorella, ma ha reagito esponendosi e lottando per tutte le altre donne, hanno risposto in molti, addirittura la Camera Penale di Venezia, che replica che “una sentenza può essere criticata tramite gli opportuni rimedi giudiziari, mentre appare un fuor d’opera farlo sui social, senza neppure avere contezza delle basi giuridiche sottese alle decisioni”. Posizione che è stata condivisa anche da altri soggetti, come la giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli, la quale, in un articolo sul Fatto Quotidiano, scrive: “È una questione tecnica, non emotiva. Dunque, accusare ‘le istituzioni’ (chi, poi?) di non proteggere a sufficienza le donne utilizzando la sentenza Turetta come parametro è in questo caso un pretesto anti-pedagogico e infondato. Il femminismo non è e non deve essere demagogia populista perché le scorciatoie demagogiche spesso generano violenza. E il femminismo non deve creare violenza, ma cultura”.
Ma quanto ardore, quanto paternalismo in queste precisazioni e nelle risposte alle parole di una ragazza che ha espresso un’opinione e lo ha fatto, peraltro, inserendo tra le righe una significativa premessa, che forse né la giornalista né i penalisti hanno letto con attenzione: “Una sentenza giudiziaria – scrive la sorella di Giulia – non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Si chiama verità giudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta. Non toglie il dolore, la violenza fisica e psicologica che la vittima ha subito”. Bastava leggere e rileggere questo passaggio per comprendere il senso di tutto il ragionamento di Elena Cecchettin. Ma forse il problema non è l’aver commentato una sentenza, il vero problema è un altro. La famiglia Cecchettin ha scelto, con dignità, di mettere il dolore nella lotta, di rendere viva e attiva la memoria di Giulia, di impegnarsi non solo per una giustizia personale, ma per qualcosa che andasse oltre, che arrivasse al Paese, che potesse contribuire a cambiare le cose nella condizione delle donne e nell’educazione al rispetto. Papà Gino e ancor più Elena sono usciti dagli schemi, non hanno rinchiuso se stessi nella figura convenzionale del familiare della vittima che soffre e non disturba, che chiede giustizia per la propria congiunta e nulla più.
In particolare, Elena Cecchettin, in quanto donna e attivista per i diritti delle donne, ha attirato le critiche più feroci, diventando bersaglio di questo senso di fastidio a causa della sua fisionomia non convenzionale, non congrua alla narrazione mainstream di una cronaca che propone quotidianamente storie di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne. Le quali, finché subiscono, finché possiamo limitarci a commemorarle con due parole di circostanza, danno poco fastidio. Mentre quando si ribellano alla forma e all’ipocrisia, quando sollevano con intelligenza delle questioni, disturbano parecchio. A loro, a differenza di come accade per i tanti, soprattutto in politica, che intervengono su ogni decisione giudiziaria, non è consentito nemmeno commentare le conseguenze culturali di una sentenza di condanna dell’assassino di una sorella. Un altro sintomo (l’ennesimo) di un Paese che, come detto, ha un serio problema con le donne.
Massimiliano Perna -ilmegafono.org






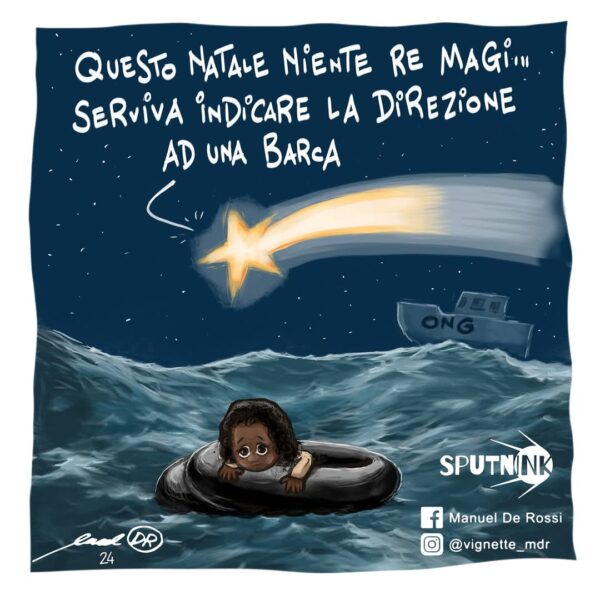
 👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢
👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti