”Salve, posso parlarle un attimo?”, è il gentile incipit del messaggio che, bene o male, chiunque ha ricevuto su WhatsApp da utenti sconosciuti, prodromo, se si dà corda, del tentativo di truffa online. Anche le caselle e-mail sono quotidianamente invase da contenuti spam, alcuni molto credibili, per mittente o contenuto. Nemmeno i più noti social network e le app più utilizzate sono al riparo dal fenomeno. Sono tentativi, sempre meno goffi e sempre più frequenti, che i più ignorano e cestinano; i meno accorti, invece, finiscono per abboccare all’amo e condividere le proprie coordinate bancarie o effettuare versamenti di denaro. Il fatturato, se così può definirsi, delle truffe digitali è da capogiro: oltre cinquecento milioni di euro, solo in Italia, nell’ultimo triennio, è la stima della Federazione autonoma bancari italiani. Non se la passano meglio negli Stati Uniti, con oltre settanta miliardi di dollari evaporati nel web, dal 2020.
E, in effetti, che si tratti di phishing, finalizzato a sottrarre dati sensibili, di spoofing e falsificazioni di identità o, ancora peggio, di pig butchering (letteralmente, macellazione del maiale), i principali destinatari delle truffe si trovano nel mondo occidentale, quel mondo nel quale moltissime forme di interazione, anche economica, transitano, ormai, dal web. Eppure, per individuare gli autori materiali, loro malgrado, delle più frequenti truffe online, bisogna spostarsi di molti chilometri verso est. Myanmar e Laos – due dei lati del Triangolo d’oro, storica regione di produzione di stupefacenti – ma anche Cambogia e Filippine, sono i luoghi nei quali si trovano dei centri di detenzione di esseri umani, dove sono rinchiusi i nuovi schiavi del mercato delle truffe telematiche. Diversamente dai percorsi di tratta che prelevano donne e uomini – spesso ingenui, spesso poco scolarizzati – dall’Africa e da alcuni paesi dell’Asia per indirizzarli verso l’Europa, in questi casi la scelta dei bersagli segue altre logiche: deve trattarsi di anglofoni e, soprattutto, di gente che, di computer, se ne intenda, possibilmente di laureati.
Le vittime sono individuate, per quel che riguarda l’Africa, in Stati, come il Kenya o lo Zambia, dai quali, normalmente, espatria un limitato numero di migranti. Anche i cittadini indiani e quelli cinesi sono un target ambito. Vengono adescati online, tramite la proposta di un lavoro ben remunerato. La sede indicata si trova quasi sempre in un luogo ameno, la Thailandia, ma, da lì, attraversano illegalmente il confine per raggiungere i nuovi lager. Myawaddy, Payathonzu e Tachileik, terre di nessuno del Myanmar, ancor più da quando, nel 2021, una giunta militare ne ha preso il potere con un colpo di Stato. Zone inaccessibili, come Van Pak Len, nel Laos, o sperdute in una delle migliaia di isolette delle Filippine, luoghi politicamente instabili ed economicamente stagnanti. Aree nelle quali, si stima, si troverebbero oltre trecentomila prigionieri (dei quali centomila solo in Myanmar), assoggettati alla criminalità locale ed alla mafia di stampo cinese.
Chi ha vissuto la realtà di questi centri e ne è uscito vivo – non deceduto per via delle percosse o vittima di asportazione illegale di organi – li ha descritti come grandi stanzoni, disseminati di postazioni dotate di computer e smartphone, circondati da filo spinato e muri di cinta invalicabili. Ai lavoratori vengono sequestrati – come sempre avviene nei casi di traffico di esseri umani – il passaporto ed il telefono. E così, bloccati in un paese straniero, senza possibilità di comunicare con l’esterno, questi nuovi schiavi lavorano tra le quindici e le ventidue ore al giorno (in modo da coprire ogni fuso orario, inclusi quelli occidentali), con un solo giorno di riposo mensile. Chi si rifiuta, viene malmenato e sottoposto ad altri trattamenti inumani, costretto, ad esempio a bere acqua sporca, finché non cede. I profili social creati sono numerosi – solo Meta, nel 2024, ne ha identificati e rimossi oltre due milioni – e si agganciano alle principali applicazioni: Facebook, Instagram, Telegram, Tinder.
Le foto sono quelle di (ignare) donne, magari raffigurate in ambito casalingo, così da essere più credibili, oppure sono scattate in loco, immortalando le più fotogeniche tra le vittime di tratta lì rinchiuse. L’approccio è stereotipato e semplice – un saluto, un invito a chattare – ma reiterato migliaia di volte. Quando qualcuno risponde al tentativo di contatto, entra in gioco il fattore umano; la capacità persuasiva di chi è costretto, per sopravvivere, ad operare l’inganno. L’obiettivo, nel caso del romance scam, è quello di conquistare la fiducia dell’interlocutore, magari facendo leva sul desiderio di avviare una relazione sentimentale, e contattarlo frequentemente, porgli domande affettuose, cementare il rapporto virtuale. Inventare, in altri termini, una identità: una persona con un lavoro, un passato da condividere, forse un divorzio alle spalle. Una persona che non esiste, ma che potrebbe essere vera.
Quando la trama è ordita, subentra la vera e propria truffa informatica: app fasulle e falsi siti web rimandano a occasioni di investimento, spesso in criptovalute. Inizialmente, i bonifici vengono parzialmente rimborsati dai truffatori, in modo da far credere che ci sia un margine di guadagno. Ma l’esito delle relazioni virtuali è sempre identico: i profili social vengono disattivati, gli adescatori spariscono. Insieme ai soldi. Come sempre accade nelle storie di traffico di esseri umani, esiste un solo modo per affrancarsi dagli sfruttatori: ripagare il proprio debito. O, meglio, ripagare il proprio “costo”: l’investimento che i trafficanti hanno affrontato per il viaggio ed il mantenimento durante la permanenza nei luoghi di detenzione. Le vittime, quindi, si ritrovano in un vicolo cieco: per ripagare e liberarsi, devono accettare le condizioni disumane di lavoro che sono loro imposte.
Lo scorso febbraio, le autorità cinesi, impensierite dalla circostanza che molti dei detenuti nel Triangolo d’oro siano loro connazionali, hanno incontrato le loro omologhe thailandesi. Queste ultime, preoccupate, a loro volta, delle ricadute in termini economici e di immagine turistica, sono intervenute, molto pragmaticamente, interrompendo il flusso di elettricità – quindi, di internet – nelle aree al confine con il Myanmar. Nei giorni seguenti, hanno liberato migliaia di persone, segregate nei centri delle truffe online. Poche settimane prima, persino un attore cinese, adescato tramite la finta offerta di un provino, era riuscito ad affrancarsi dalle maglie della criminalità birmana. Insieme a lui, centinaia di cittadini, non solo cinesi, aspettano il rimpatrio.
Nel frattempo, nonostante questa battuta d’arresto, il circuito delle truffe digitali – e, con esso, il mercato di esseri umani – rimane fiorente. Neppure la sempre maggiore diffusione dell’intelligenza artificiale potrà sostituire le sfumature emotive proprie dell’interazione umana e, quindi, la ricerca di giovani abili con i PC da impiegare negli inganni online. I nuovi carnefici, che sono in realtà – anche e soprattutto – le nuove vittime.
Sophie M. -ilmegafono.org





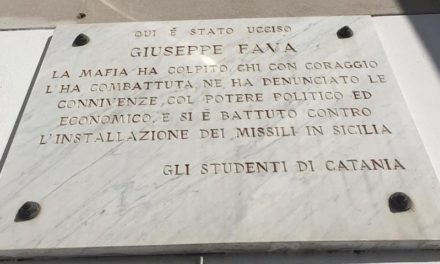

 👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢
👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti