Qualche giorno fa, il 22 maggio 2024, presso l’Accademia delle Scienze di via Zamboni, a Bologna, è stato presentato “Respond – Rescuing democracy from political corruption in digital societies”, un progetto europeo coordinato dall’Università di Bologna e finanziato dall’Unione Europea, che ha visto Unibo guidare un consorzio di 16 partner provenienti da 12 paesi europei, con la prof.ssa Alice Mattoni nel ruolo di coordinatrice scientifica. Obiettivo principe del progetto: fare luce sulla corruzione politica, un problema globale che minaccia non solo i servizi pubblici vitali, ma anche la salute stessa delle democrazie. La ricerca ha adottato un approccio multidisciplinare volto a esplorare varie forme di influenza politica tipiche delle così dette zone grigie della legalità, tra cui il finanziamento alla politica, il lobbismo, il fenomeno delle “revolving doors” (porte girevoli), i conflitti d’interesse e le forme di influenza e pressione politica sui media.
In un Paese come l’Italia, ad esempio, dove le mafie sono potenti e, molto spesso, colluse con il potere politico e finanziario, il fenomeno delle “porte girevoli” è altamente pericoloso. Diffuso nel sistema della politica statunitense, il movimento continuo di persone divise tra attività politica, attività di lobbying per conto di gruppi industriali o come funzionari in enti di regolamentazione o in attività economiche in grandi industrie, diventa insidioso per la tenuta democratica e per la legalità. L’Italia, come è facile immaginare, non è affatto esente da questa problematica e oggi, più che in altri periodi, visti gli eventi giudiziari che hanno colpito anche esponenti della maggioranza di governo, occorre porvi rimedio prima che sia troppo tardi.
“Nonostante la proliferazione degli scandali in tutta Europa, la ricerca sulle forme di corruzione politica nelle società contemporanee, fortemente digitalizzate, è sorprendentemente limitata: sono ancora pochi gli studi che analizzano come forme legittime di influenza politica possano trasformarsi in casi di influenza indebita”, spiega la professoressa Mattoni a Unibo Magazine.
Il progetto si è posto quattro obiettivi fondamentali:
- generare nuovi dati e nuove conoscenze sulla corruzione politica oggi, con particolare attenzione ai finanziamenti alla politica, alle lobbying, alle connessioni personali e familiari, alle “porte girevoli”, alle pressioni sui media (il recente esempio italiano di assalto alla RAI è emblematico);
- esplorare il ruolo delle tecnologie digitali nel perpetuare la corruzione politica;
- mirare a valutare, con sondaggi, analisi di casi di studio e studi sul ruolo dei social media, l’impatto della corruzione politica sulla salute della democrazia;
- studiare, co-sviluppare, testare e perfezionare strumenti e metodologie per affrontare la corruzione politica.
Tra i partner del progetto c’è anche l’associazione Libera, segno che la connessione mafie-corruzione politica esiste e la storia del nostro Paese, purtroppo, lo dimostra. Ma il problema riguarda tutti i Paesi europei ed extraeuropei, nessuno escluso. A neanche un mese dalle elezioni europee, infatti, non si può non ricordare l’inchiesta Qatargate nella quale è indagata l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili.
Dove c’è corruzione e dove la corruzione diventa sistema non può esserci futuro, non può esserci sviluppo, non può esserci democrazia. Torna allora alla mente una provocazione di Bertold Brecht che scrisse: “La corruzione è la nostra unica speranza. Finché c’è quella, i giudici sono più miti, e in tribunale perfino un innocente può cavarsela”. In verità, la speranza che, a partire da questa ricerca scientifica, qualcosa cominci a delinearsi in Europa contro la corruzione, è alta, anche se la realtà di spazio alle speranze ne lascia davvero pochissimo.
Vincenzo Lalomia -ilmegafono.org


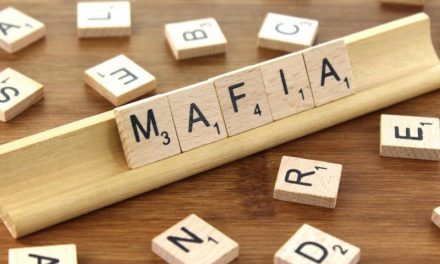




 👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢
👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti