Ankara, 10 ottobre 2015, Turchia: migliaia di persone, soprattutto turche e curde, unite nell’identica volontà pacifista, si radunano e si preparano a mettersi in cammino per chiedere “pace, lavoro, democrazia” in un paese segnato dalle tensioni, dalla violenza generata da anni di passi indietro, di restrizioni democratiche e repressioni sanguinose orchestrate dal presidente conservatore Erdogan. Una marcia per la pace, una giornata di sorrisi che si mischiano agli ideali e al sogno di un mondo migliore. Una marcia che, però, non è mai partita. Strozzata, sventrata dalle bombe, spezzata dalle schegge e dall’esplosivo: oltre cento morti, più di cinquecento feriti. Niente più “pace, lavoro, democrazia”, solo i lamenti dei sopravvissuti e il silenzio funesto di chi non ce l’ha fatta.
Ankara piange, mentre la Turchia si interroga, tra polemiche e accuse reciproche. Il coro pacifista è stato messo a tacere ancora una volta. Erdogan mostra al mondo il suo ipocrita e poco credibile sentimento di lutto nei confronti di persone colpite “mentre uscivano dalla stazione”, come egli ha detto, senza fare appositamente riferimento al fatto che si trattasse di cittadini in attesa di iniziare un corteo pacifista. Le ipotesi si sprecano, gli osservatori internazionali cercano di capire. In questo caos di congetture, ciò che alla fine brucia di più è la ferita tremenda subita da quegli uomini e quelle donne che hanno ancora il coraggio di scendere in piazza per un ideale che, secondo alcuni, è ormai passato di moda.
I pacifisti turchi e curdi, e tutti quelli che erano ad Ankara al loro fianco, sono il simbolo di una umanità che prova a non arrendersi, dentro a un mondo nel quale le guerre, il terrore, le frontiere spietate, i muri, gli eserciti e i regimi sono il pane quotidiano di decine e decine di popolazioni e nazioni. Erano in piazza per dimostrare che, anche in mezzo a questo mondo, ci sarà sempre un coro di voci pronte a intonare parole di pace, trainate da piedi in marcia, mani che stringono altre mani o impugnano bandiere, cartelli, striscioni. Chiunque sia l’assassino che ha insanguinato Ankara, l’obiettivo era proprio quello di centrare quel simbolo, di terrorizzare quella resistenza civile, di scoraggiare l’idea di un popolo che rifiuta le misure illiberali e il conflitto in nome dell’unità e della convivenza pacifica.
Eppure, quel simbolo non è crollato, l’obiettivo non è stato centrato. Il sangue e le bombe non hanno fermato chi chiede una Turchia diversa. Il giorno dopo la strage, infatti, migliaia di cittadini sono scesi nuovamente in piazza, ad Ankara, contro la violenza e per ricordare le vittime dell’attentato. Hanno mostrato di non aver paura, di non arrendersi, di non rinunciare al proprio sogno di libertà e pace. Un gesto che, probabilmente, chi ha mandato i kamikaze tra la folla del 10 ottobre, non aveva previsto, non si aspettava. Non se lo aspettavano in tanti. Di fronte ai manifestanti turchi e curdi e al loro coraggio, viene allora da chiedersi che fine hanno fatto gli altri. Dove sono finiti i pacifisti di tutto il mondo? Dove si nascondono quelli che non tacevano mai, che spuntavano nelle piazze di tutto il pianeta per ribellarsi a guerre spesso lontane da casa loro?
Di fronte a chi ad Ankara, il giorno dopo le bombe, è tornato in piazza, si avverte un silenzio imbarazzante, lacerante. Il movimento pacifista internazionale sembra non esistere più, non avere abbastanza voce, appare afono, minimo, intermittente. O semplicemente disperso e forse rassegnato. Eppure è stato importante, decisivo in tanti momenti storici. Ha creato coscienza, consapevolezza, ha fatto da antidoto alle violenze e alle logiche guerrafondaie di governi di tutto il mondo. Basti ricordare il movimento ai tempi del Vietnam, ma anche più recentemente quelli contro le due guerre in Iraq e contro l’intervento in Afghanistan, oppure contro i bombardamenti nella ex Jugoslavia. Oggi i conflitti non sono diminuiti, tutt’altro. Sono durissimi e diffusi, le bombe scoppiano, i proiettili vengono sparati e le repressioni, in molti paesi, fanno scorrere tanto sangue quanto quello delle guerre.
Il pacifismo, in molte parti del mondo, soprattutto nelle democrazie “occidentali”, si è inabissato, mostrandosi incapace di reagire alle volgari degradazioni di chi parla di ideologizzazione dei movimenti, presentandoli come oggetto prediletto di basse strumentalizzazioni politiche. Così il movimento appare frantumato, ridotto alla forma del semplice e poco partecipato presidio, che merita enorme rispetto ma che non riesce ad amplificare la propria voce e le ragioni chiarissime e inoppugnabili delle posizioni pacifiste. In Italia ci siamo fermati del tutto, ci limitiamo a qualche grosso evento, come la marcia di Assisi, e null’altro. I girotondi, il popolo colorato, le personalità che sembravano incarnare un risveglio, una nuova consapevolezza, un modo nuovo, umano, pacifico di guardare il mondo sono tornati a prendere polvere in cantina o dietro queste maledette tastiere che ci imprigionano.
Sono stati commessi errori, è vero, ma forse la ragione delle ragioni è che si è smesso di occuparsi di ciò che accade nel mondo, di ritenerlo prioritario, forse ci si è sentiti impotenti, di sicuro si è smesso di pensare che lo stesso giorno della manifestazione di Ankara e il giorno successivo, anche in Italia e in altre nazioni europee (e non solo), avremmo dovuto riempire le piazze per chiedere “pace, lavoro, democrazia”, ben sapendo che l’orrore della guerra riguarda tutti. Anche quelli che pensano che il pacifismo sia inutile o vintage e sbuffano o imprecano quando un corteo di bandiere colorate, cartelli, striscioni, slogan e mani che stringono mani occupa le loro strade e sfila sotto i loro balconi e uffici, cercando di offrire a tutti un po’ di umanità e coscienza. E provando a ricordare a tutti che anche quel avviene lontano da noi è affar nostro. Perché ad Ankara ci potevamo e dovevamo essere anche noi.
Massimiliano Perna –ilmegafono.org





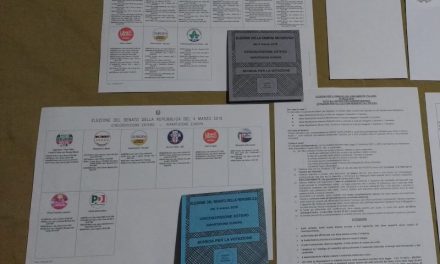

 👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢
👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti